GALILEO, oltre le stelle - di Corrado D'Elia
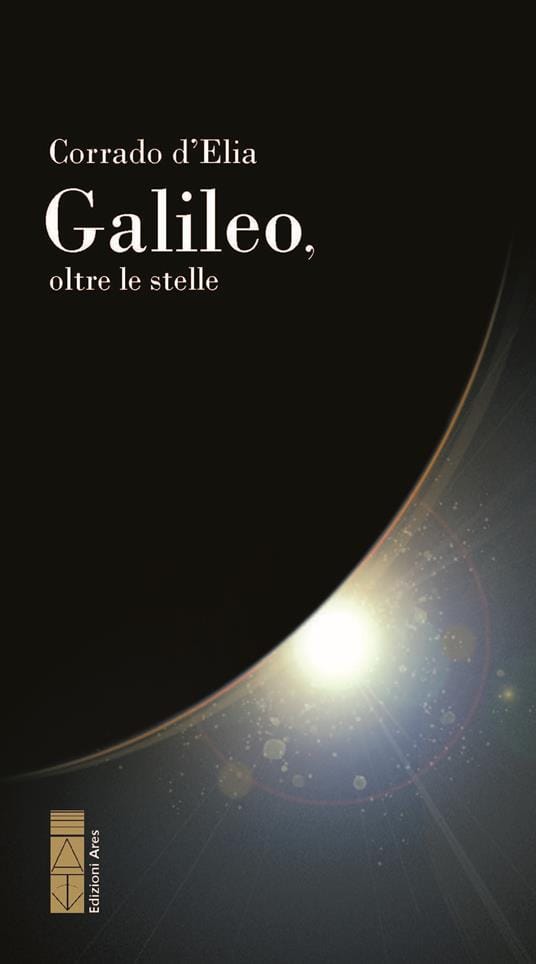
𝐒𝐜𝐡𝐞𝐝𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨
𝐓𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨: Galileo, oltre le stelle
𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞: Corrado d’Elia
𝐏𝐫𝐞𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Gabriella Greison
𝐏𝐨𝐬𝐭𝐟𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞: Chiara Salvucci
𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞: Edizioni Ares
𝐂𝐨𝐥𝐥𝐚𝐧𝐚: Narratori
𝐀𝐧𝐧𝐨: 2025
𝐏𝐚𝐠𝐢𝐧𝐞: 152
𝐈𝐒𝐁𝐍: 978-88-9298-660-2
𝐏𝐫𝐞𝐳𝐳𝐨: € 11,00
𝐀𝐜𝐪𝐮𝐢𝐬𝐭𝐨: https://www.edizioniares.it/prod.../galileo-oltre-le-stelle/
Corrado d’Elia – con la prefazione di Gabriella Greison che lo incornicia da fisica e narratrice della scienza – assume Galileo come figura-limite: l’uomo che inaugura una maniera nuova di stare davanti al mondo, sapendo che ogni verità è provvisoria e ogni risposta è soltanto l’ultima tappa di una serie di domande ostinate. Non è il padre imbalsamato della “rivoluzione scientifica”; è il corpo vivo di una filosofia della scienza che nasce dal dubbio, dall’errore, dalla paura, dalla necessità di continuare comunque, e che fa della libertà non uno slogan ma la fatica quotidiana di guardare il mondo senza abbassare gli occhi.
Greison mette subito l'evidenza: Galileo è un compagno di strada in un presente che ha di nuovo paura del dubbio. Il suo “cuore inquieto” diventa il modello di un atteggiamento mentale: non accontentarsi dell’autorità, non fermarsi alla tradizione, non confondere la quiete con la verità. La prefatrice insiste su un punto che il testo teatrale sviluppa per tutta la sua lunghezza: la scienza come storia di persone che non riescono a dormire perché qualcosa non torna. La lampada che oscilla in chiesa, la pietra che cade, la Luna che sotto il cannocchiale rivela montagne e crateri: non sono solo immagini sceniche, sono il catalogo minimo di una epistemologia concreta, fatta di attrito tra esperienza e racconto.
D’Elia segue il filo biografico con pochi ma precisi chiodi: il giovane Galileo che osserva e misura, il docente precario che a Padova si divide tra lezioni, esperimenti, oroscopi per i potenti; poi la svolta del cannocchiale, l’ascesa a Venezia, il successo di corte e l’ingresso nei salotti dove si decidono carriere e condanne. Sullo sfondo si muovono le ombre pesanti di Giordano Bruno bruciato a Campo de’ Fiori e del cardinale Bellarmino, che incarna la Chiesa colta ma spaventata dal nuovo. Quando arriva Urbano VIII, papa intelligente e vanitoso, il Dialogo sembra possibile: nasce in italiano, in forma di confronto "aperto", ma la figura di Simplicio e il gioco troppo scoperto fra i sistemi cosmologici gli si ritorcono contro. Da lì parte il percorso al contrario: il viaggio di un vecchio malato verso Roma, la peste tutt’intorno, le stanze del Sant’Uffizio, il processo, la minaccia della tortura, l’abiura come crollo necessario. La parabola si chiude ad Arcetri, tra cecità, fragole piantate in giardino e lettere con Virginia, mentre la condanna ecclesiastica continua a pesare sulla memoria dello scienziato fino alla tardiva riabilitazione del Novecento: segno che il tempo della Chiesa e il tempo della scienza non corrono mai alla stessa velocità.
Il monologo fa recitare a Galileo una filosofia della scienza che si riconosce subito: il sapere non viene dall’adesione a un dogma, viene dalla frizione tra ciò che vediamo e ciò che il dogma ci dice di vedere. Le “domande selvagge” che attraversano il bambino e l’anziano sono la versione teatrale di quello che noi chiamiamo metodo: non c’è formula senza un prima di disagio, di sospetto, di curiosità. Prima di essere equazioni, le scoperte sono crepe. La scelta di insistere sui gesti minimi – contare le oscillazioni, lanciare oggetti, misurare piani inclinati – è il modo più diretto che il libro trova per dirti che la scienza comincia quando smetti di prendere il mondo come sfondo e inizi a trattarlo come interlocutore.
La scrittura tiene insieme tutto questo con un registro doppio che funziona: da una parte la prosa in terza persona, piana, quasi da cronaca narrata, che scorre senza inciampi tecnici; dall’altra i blocchi in versi liberi, che sono il vero motore teatrale del libro. Non c’è mai compiacimento lessicale, non c’è la tentazione della “pagina letteraria” fine a sé stessa: le frasi sono brevi, concrete, costruite per la bocca più che per l’occhio. Si sente che il testo nasce per la scena: anafore, ripetizioni, triadi, immagini nette che chiedono una luce, un respiro, un silenzio. La sintassi non fa il fenomeno, accompagna l’attore: gli offre appoggi, cadenze, stacchi. L’alternanza fra racconto e monologo interno dà ritmo senza spezzare il filo, e soprattutto restituisce il cuore della teatralità qui in gioco: un solo corpo in scena che non “recita Galileo” ma lo attraversa, passa dalla descrizione all’io, dal ricordo al processo, senza cambiare dispositivo. La dimensione teatrale non è un accessorio: è la forma stessa del pensiero che il libro mette in piedi, il dubbio come voce che ritorna, il dialogo fra fede e scienza ridotto a scontro di registri, il processo trasformato in sequenza di respiri e mezze frasi.
La postfazione di Chiara Salvucci porta questo stesso gesto sul piano dello spazio: racconta un palcoscenico fatto di lenti, luce e geometrie minime, dove l’esperimento scientifico diventa dispositivo visivo. Le sue pagine chiudono il libro ricordando che anche la scena è un laboratorio, una macchina poetica che tiene insieme rigore, rischio e meraviglia e invita lo spettatore a essere, almeno per un istante, ostinato come Galileo nel guardare oltre l’ovvio. Da questa idea di scena‑laboratorio il libro scivola senza strappi verso il terreno più esposto, quello in cui fede e scienza devono ancora una volta imparare a spartirsi il modo di guardare il mondo.
Il rapporto con la fede viene trattato non come “guerra fra due mondi”, ma come problema di linguaggi. Nel testo la Bibbia e il cannocchiale non si annullano; sono due scritture diverse che rischiano l’equivoco quando si pretende di usare l’una per fare il lavoro dell’altra. Galileo non è l’ateo militante, è il credente che difende il diritto di leggere il cielo con gli strumenti adatti. Questo è un punto decisamente filosofico: l’idea che ogni discorso abbia il suo dominio di validità, che la scienza parli del “come” e la teologia del “perché”, e che il vero disastro cominci quando una delle due pretende di occupare tutto il campo. Il monologo fa passare questo conflitto come tensione drammatica, ma sotto c’è un pensiero preciso: la verità non è proprietà di un’istituzione, è una convergenza lenta di sguardi e misure.
C’è poi il tema dell’errore, che Greison conosce benissimo da fisica e che il libro spinge fino in fondo. Galileo sbaglia, arranca, fa compromessi, si vende a volte agli stessi potenti che lo ostacoleranno. Ma questo non viene presentato come macchia, viene mostrato come condizione di possibilità. Una scienza che non prevede l’errore non esiste; esistono solo apparati ideologici che si travestono da conoscenza. Nel monologo l’errore non è un incidente, è il metodo: aggiustare il cannocchiale, ricalcolare le orbite, correggere le proprie stesse ipotesi. Tutto questo si intreccia con la fragilità biografica – la precarietà economica, la vecchiaia, la malattia – e disegna una figura di scienziato pienamente moderna: non l’uomo infallibile che vede oltre, ma l’uomo che sa di non vedere bene e proprio per questo costruisce strumenti migliori.
Il processo e l’abiura diventano allora il banco di prova di questa filosofia della scienza. Non sono solo la scena forte di un dramma giudiziario, sono il punto in cui la responsabilità verso la verità si scontra con la responsabilità verso la propria vita e verso chi ti è legato. Il Galileo di d’Elia non rinnega il movimento della Terra nella sua testa: rinuncia a dirlo pubblicamente nelle forme che l’Inquisizione gli impone di abbandonare. La scienza, qui, non è eroismo puro né codardia: è una linea di continuità che sopravvive ai singoli atti, anche ai più umilianti. L’idea che passa è che la verità fisica non va in prigione con il suo portatore; continua a lavorare sottotraccia, nei libri, nelle misure, nelle menti degli altri. Il gesto di abiura non chiude il percorso, ne cambia soltanto il pathos.
In fondo, il libro porta a casa una cosa: la filosofia della scienza di Galileo – letta attraverso la lente teatrale di d’Elia e quella fisica-narrativa di Greison – è una filosofia dell’inquietudine organizzata, cioè di una libertà che si misura sui rischi che accetta e sulle domande che non smette di fare. Non basta dubitare; bisogna mettere il dubbio alla prova, costruire esperimenti, accettare il rischio, pagare i prezzi, tenere aperto il cantiere. La scienza non appare come blocco di verità acquisite, ma come pratica fragile, umana, storica, che dipende dal coraggio di pochi e dalla lentezza di tutti. E questo, per uno spettatore che oggi si barcamena tra complottismi, negazionismi, certezze urlate e sfiducia nei dati, è un messaggio molto meno consolatorio di quanto sembri: non esistono scorciatoie, esiste solo il lavoro lungo di chi guarda una lampada che oscilla e ha il coraggio di dire: “qui c’è qualcosa che non torna”.
— 𝗠𝗶𝗿𝗼 𝗥𝗲𝗻𝘇𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮